Anversa degli Abruzzi
Anversa degli Abruzzi è un piccolo gioiello in pietra incastonato tra le spettacolari Gole del Sagittario e il crinale del Monte Sant’Angelo. Qui, in un paesaggio selvaggio e suggestivo, l’antico abitato di Castrovalva si affaccia come un balcone sospeso sul vuoto. Siamo nel cuore di una Riserva Naturale WWF, tra sorgenti limpidissime, fauna selvatica e sentieri silenziosi immersi nella natura.
Il centro di Anversa ruota intorno a Piazza Belprato, dominata dalla maestosa Chiesa di Santa Maria delle Grazie, notevole esempio di romanico abruzzese. Il suo portale rinascimentale, arricchito da un gruppo scultoreo della Deposizione, è sormontato da un rosone che cattura lo sguardo. L’interno è a tre navate con volte a crociera e una cupola sorretta da pilastri. Sullo sfondo si staglia il protagonista silenzioso della storia di Anversa: il Castello Normanno. Edificato nel XII secolo dalla famiglia Di Sangro come sede di controllo giurisdizionale, fu trasformato dai Belprato in una residenza rinascimentale. Abbandonato nel Settecento, oggi è una residenza privata.
Il borgo nacque attorno all’incastellamento normanno di fine XI secolo e si ampliò nel corso del Trecento. Ancora oggi conserva Porta Pazziana e Porta San Nicola, oltre alla suggestiva Via degli Archi, con le sue bifore e i portali bugnati. Meritano attenzione anche le Case dei Lombardi e la piccola piazzetta mercantile, dove un tempo si svolgeva la vita commerciale del borgo. Tra le architetture sacre spicca infine la Chiesa di San Marcello, dedicata al patrono del paese. Fondata nel XII secolo, la chiesa fu arricchita nei secoli successivi con un portale in stile neogotico e affreschi quattrocenteschi che impreziosiscono l’interno.
Poco prima di giungere ad Anversa, lungo la strada proveniente da Sulmona, è visibile sul lato destro della carreggiata una parete ghiaiosa con i resti di una necropoli del IV-III secolo a.C. L’antico sepolcreto, già identificato da Antonio De Nino alla fine dell’Ottocento, era costituito da tombe a camera scavate nella ghiaia, cosiddette a cripta o a grotticelle.
Lungo la strada che collega il paese a Cocullo, in località Coccinelle, presso il cimitero di Anversa, è stata indagata una necropoli coeva alla precedente. (dal IV secolo a.C. in poi) ma con tombe a fossa rettangolare, scavate nel terreno, foderate e ricoperte con lastre di pietra calcarea. La presenza di due necropoli distinte, con tipologie funerarie diverse ma cronologicamente coeve, attesta che il territorio di Anversa era già abitato nel periodo preromano, verosimilmente da più nuclei insediativi diffusi sul territorio.
OASI Gole del Sagittario
Le impervie Gole del Sagittario, scenario descritto in modo suggestivo da illustri scrittori e viaggiatori, sono una spaccatura profonda formatasi per erosione fluviale: Il fiume correva impetuoso e spumeggiante, spesso allagando l’antico sentiero che lo fiancheggiava. Tra il 1882 e il 1892 fu quindi realizzata, per risalire la valle, una strada tagliata nella roccia e a strapiombo sul fiume. Negli anni ’20 la realizzazione di una diga a monte ha ridotto la portata del corso d’acqua da 2000 a 300 litri al secondo. Il nome originario del fiume era Flaturno. Il nome Sagittario, relativamente recente, deriva dal decurione romano Lucio Obidio Sagites, citato in un’iscrizione funeraria. Nel 1991 è stata istituita, intorno alle sorgenti del Cavuto e lungo il fiume, un’oasi WWF (una superficie di 450 ettari), divenuta poi Riserva Naturale della Regione Abruzzo, che include un centro visite, un centro appenninico per la fauna rupestre e un giardino botanico. Nella zona transitano lupi, cervi, cinghiali e orsi, e le pareti rocciose circostanti sono habitat ideale per aquila reale, falco pellegrino, gracchi corallini e rondini montane. Altrettanto varia è la flora, passando da specie acquatiche ai bordi del torrente a specie che amano l’aridità delle pareti rocciose. Sono state censite 461 specie animali e 789 specie vegetali.
Borgo di Castrovalva
Castrovalva gode di una posizione dominante e facilmente difendibile, un sito frequentato sin dal Paleolitico. Nell’alto Medioevo, sul crinale di Monte San Michele, si costituirono gli insediamenti fortificati del Morrone e del Castellaccio, ed ebbe origine la denominazione “Castro”, mentre la dicitura estesa Castrum de Balba comparirà solo dal 1289.
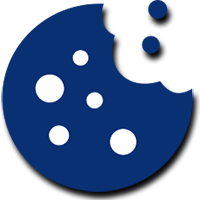












 per installare la App sul tuo
per installare la App sul tuo
