Sulmona
La città di Sulmona, l’antica Sulmo, fu fondata secondo la leggenda da Solymus, compagno di Enea. Sulmona viene ricordata dagli autori antichi nel corso delle guerre puniche e durante la Guerra Sociale.
Distrutta da Silla secondo le fonti, alla fine del I sec.a.C. fu ricostruita e trasformata in municipium. Nel 49 a.C. subì l’assedio di Cesare, nel corso della guerra civile contro Pompeo, e dovette arrendersi al grande
condottiero. Qui nacque nel 43 a.C. il poeta Ovidio. La città conserva nel reticolo stradale medievale gran parte dell’impianto urbanistico antico.
La visita parte dalla Cattedrale di S. Panfilo ,
posta a delimitare l’estremità settentrionale dell’abitato, sorta secondo la tradizione nell’VIII secolo su un preesistente tempio dedIcato ad Apollo e Vesta. La storia attualmente leggibile della chiesa inizia dalla
cripta , datata all’anno 1075, divisa in 3 navate trasversali
da 16 colonne, poi ridotte a 14 per far posto all’altare seicentesco in cui sono custodite le spoglie del Patrono. Vi si conservano opere di epoca medievale, come il bassorilievo in pietra della Madonna con bambino (XII secolo),
la cattedra vescovile (XIII secolo),
assemblate allo schienale molto più tardo e ancora il monumento funebre di un cavaliere; il sepolcro, seconda metà del trecento, è inquadrato in un arco gotico addossato alla parete, decorato da un affresco
rappresentante la Madonna in trono col bambino tra l’arcangelo Michele e S. Giovanni Battista. dell’ impianto medievale della chiesa soprastante, dopo il terribile terremoto del 1706, resta unicamente il colonnato in
pietra che divide lo spazio interno. Lungo la navata destra si conserva un crocifisso ligneo. All’esterno dell’edificio, la cornice marcapiano a foglie di acanto divide la parte superiore della facciata, ricostruita
dopo il sisma, da quella inferiore in cui si apre il portale centrale archiacuto, affiancato da una coppia di leoni stilofori, che sostengono le due edicole con le statuette di S. Panfilo, titolare della chiesa, e di S. Pelino
vescovo di Valva, a riferimento all’unificazione delle due diocesi (XIV sec). Nella lunetta è affrescata una deposizione quattrocentesca, attribuita al maestro della cappella Caldora. Il portale laterale , che si apre a
sinistra, romanico, presenta una iscrizione sull’architrave e un frammento di epigrafe romana murato nella lunetta. Romaniche pure le tre absidi
decorate ad archetti pensili poggiate su mensole con figure umane e motivi vegetali.
Percorrendo corso Ovidio possiamo raggiungere il palazzo della SS Annunziata :
la chiesa e l’annesso palazzo, edificati nel XIV secolo dalla confraternita della Penitenza, costituiscono il complesso monumentale più rappresentativo della città di Sulmona. L’edificio fu colpito duramente da vari eventi sismici:
il campanile che oggi possiamo ammirare viene dalla ricostruzione cinquecentesca, la facciata è stata ricostruita interamente dopo il sisma, come pure la chiesa che si presenta in forme barocche. Sotto il complesso è
stata rinvenuta una domus (I sec.a.C.- II sec.d.C.) con pavimenti a mosaico e tracce della originaria decorazione pittorica parietale in cui è possibile riconoscere scene collegate alle nozze di Dioniso e Arianna e alla disputa tra il
dio Pan ed Eros. Tutto il complesso è stato musealizzato e reso visitabile ed è quindi possibile riconoscere la stratificazione cronologica fino alle forme attuali.
All’interno del palazzo é visitabile il Museo Civico ,
comprendente una sezione medievale-moderna con raffinati esempi di oreficeria sacra, ed una archeologica con reperti provenienti dalla città antica e dal territorio e databili tra la preistoria e la tarda età romana,
organizzato in sale distribuite su due livelli: la prima, al piano terra, è dedicata al periodo pre–protostorico ed italico; la seconda, al piano superiore, all’epoca romana. A poca distanza dalla S.S. Annunziata,
sulla via Stella, si trova la chiesa di San Gaetano
che conserva al suo interno vari ambienti di una residenza di età romana (II –III sec.d.C.) con pavimenti mosaicati o con inserti marmorei.
Proseguendo lungo corso Ovidio ci troviamo di fronte la chiesa di S. Francesco della Scarpa (XIII sec)
importante edificio medievale fortemente danneggiato dal sisma del 1706. della facciata originaria si conserva il portale ogivale che, nella lunetta, contiene un affresco di Madonna del latte. L’attiguo edificio conventuale ospita
oggi la sede del Comune di Sulmona. L’ingresso laterale della chiesa si trova sul corso, con un monumentale portale affrescato nella lunetta. Il dipinto, del ‘500, raffigura la Madonna con bambino tra S. Francesco e S. Maria Maddalena.
A sinistra del portale una torre campanaria del XV sec.
Di fronte si snodano le 21 arcate dell’acquedotto
costruito nel 1256 regnante Manfredi di Svevia. A ridosso dell’acquedotto è collocata la fontana “del Vecchio” (XV sec).
La fontana presenta un mascherone centrale dal quale sgorga l’acqua e con incisa la parola Vecchio.
Attraverso i monumentali archi ogivali si apre alla vista lo spazio di piazza Garibaldi ,
l’antica piazza Maggiore, sede del mercato già in età Sveva.
Sulla piazza affacciano importanti edifici medlevali. Ad una estremità dell’acquedotto si trova il complesso monastico di S. Chiara (XII sec),
ricostruita dopo il terremoto del ‘7oo. All’interno si conserva la tomba della Beata Floresella da Palena, fondatrice dall’attiguo convento delle clarisse. Il complesso ospita il Museo diocesano di arte sacra.
Le opere, databili tra il XII e il XIX sec, provengono dagli edifici sacri della città e della Diocesi.
In fondo alla piazza la chiesa di S. Filippo Neri
alla cui facciata fu addossata la facciata proveniente dalla chiesa di S. Agostino, sita nei pressi della villa comunale e distrutta dal terremoto settecentesco. Il portale ogivale è ornato da un rilievo scultoreo raffigurante S. Martino che dona il mantello.
Ritornati su corso Ovidio si percorrono pochi metri e, sulla destra, si apre la piazza di S. Maria della Tomba (XII sec),
edificio romanico a coronamento orizzontale. In facciata un rosone del 1400 e strutture successive tardomedievali. Al fianco destro fu costruito (1426) un edificio destinato a ospedale e di cui resta solo la facciata. Negli anni 60 S. Maria della tomba fu assoggettata ad un radicale intervento di restauro.
Proseguendo per il corso incontriamo, sulla destra, la chiesa trecentesca di S. Lucia , annessa al convento delle Benedettine, il cui chiostro è oggi compreso in una struttura privata.
Pochi metri dopo la monumentale porta Napoli costruita alla fine del duecento,
la facciata esterna è decorata a bugnato rustico che si appiattisce verso l’alto. Ancora nell'ottocento la porta era affiancata da tratti di mura pertinenti alla cinta muraria medievale. Da porta Napoli è possibile seguire
un itinerario “lungo le mura” .
Si percorre la circonvallazione orientale e poi quella occidentale, si incontra porta Saccoccia (epoca incerta con elementi oggi riferibili al XVIII secolo). seguendo il tracciato delle mura arriviamo a
Porta Pacentrana il cui arco ogivale era la porta
di accesso al borgo omonimo. Nelle vicinanze, sul cantonale di palazzo Sardi, sono visibili resti della porta Manaresca, probabilmente parte della cinta muraria più anctica. Ritornati sulla circonvallazione orientale è possibile raggiungere
la rampa di accesso di porta Japasseri di cui si conserva una parte della cortina muraria che termina in una torre cilindrica. Si prosegue e, attraversando piazza Carlo Tresca, si va verso la parte opposta e si raggiunge la circonvallazione occidentale
dove si apre porta Romana (1429) che presenta un arco a tutto sesto.
A destra una rampa ricollega a porta Bonomini. Lungo l’asse inquadrato da questa porta si trova porta Molina, da questo punto percorrendo una discesa si ritorna sulla circonvallazione e,
di li a poco, si raggiunge porta S. Antonio con arco ad ogiva.
La porta sostituì la soprastante porta Filiamabili, anch’essa a sesto acuto, posta a chiusura dell’abitato antico. Non distante sorge porta S. Maria della Tomba
che prende il nume dalla vicina chiesa.
Alle pendici del Monte Morrone, a circa Km.7 da Sulmona, si raggiunge l’Abbazia di S. Spirito al Morrone.
Nell’Abbazia la storia di Pietro Angelerio si confonde con quella del complesso architettonico che, attraverso i secoli, ha segnato i vari passaggi della vita dell’eremita, divenuto papa Celestino V, e dell’Ordine da lui fondato.
Dall’iniziale ampliamento della piccola chiesa di Santa Maria si passò alla costruzione del nuovo edificio sacro e dell’annesso convento; sarà questa la sede dell’Ordine, sulla base del Capitolo Generale tenutosi del 1293.
Oggi, dopo gli interventi seguiti al terremoto del 1706, cinque cortili scandiscono lo spazio interno racchiuso da un muro di cinta quadrangolare; la chiesa settecentesca , con la facciata che rimanda a quella di San Carlino alle Quattro Fontane a Roma, si eleva nel primo dei cortili, denominato “dei Platani” . Lungo il lato sud-est si colloca il Refettorio, con pitture murali monocrome del 1717-1719 di Frate Joseph Martinez e ricche decorazioni in stucco. Uno scalone monumentale dà accesso al primo piano, mentre ampie porzioni del complesso sono in corso di restauro. Dopo la soppressione dell’Ordine dei Celestini, a seguito della emanazione della legge napoleonica del 1806, l’Abbazia è stata utilizzata per varie destinazioni: Collegio Reale dei tre Abruzzi, ospizio di mendicità e quartiere militare con annesso
ospedale. Dal 1868 al 1993 tra queste mura è stata ospitata una casa di reclusione, mentre dal 1998 è stata avviata una nuova fase che ha portato alla restituzione alla comunità dell’importante struttura, oggi visitabile.
Eremo di Celestino V
Sul Morrone Pietro Angelerio, chiamato anche Pietro da Morrone, nel 1294 fu raggiunto dai messi di Carlo II d’Angiò che lo informarono della sua elezione a Papa e lo condussero nella Basilica di Collemaggio all’Aquila per la solenne
incoronazione, con il nome di Celestino V. L’eremita si era spostato in vari luoghi, alla ricerca della necessaria solitudine: dapprima a S. Maria al Morrone, poi a Santo Spirito sulla Maiella e di nuovo sul Morrone, in una grotta a 620 metri s.l.m.
Qui tornò dopo il “gran rifiuto” al soglio pontificale, come definito da Dante nel Canto III dell’Inferno; numerosi pellegrini, richiamati dalle sue virtù, accorsero sul Morrone e gli spazi furono adattati a questa nuova
realtà. Il luogo di culto subì un pesante danneggiamento durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale; il restauro successivo ha in parte modificato l’aspetto originario. Dal piazzale sottostante, un sentiero conduce
all’eremo, caratterizzato da un loggiato di dieci finestre con arco a tutto sesto, soffitto ligneo e affreschi risalenti al XV secolo; al primo piano è situato l’oratorio, in cui si conservano affreschi e le due celle di Pietro e
Roberto da Salle, suo discepolo. Da una scalinata si accede alla terrazza panoramica dalla quale si spazia su tutta la valle Peligna; la tradizione vuole che da questo punto i fedeli lancino sassi verso il basso a simboleggiare l’allontanamento dalle
tentazioni. Da qui si accede alla grotta dove Pietro si ritirava in preghiera. (1514)
Partendo dalla Badia si prosegue lungo la salita, su un percorso che termina proprio all’accesso dell’imponente terrazzamento occupato da un santuario
italico dedicato ad Ercole Curino . Già conosciuto in gergo popolare come le “potéche d’Ovidio”, il complesso religioso sorse su un luogo sacralizzato
probabilmente già in epoca precedente al suo impianto ( IV-III sec.a.C.), in prossimità di sorgenti naturali. In epoca romana venne ampliato e trasformato, giungendo alle forme attuali, articolate su due terrazze ben sostruite.
La terrazza inferiore , fortificata da un possente muraglione a gradoni
in opera incerta, era caratterizzata da una serie di ambienti con copertura a volta, in parte ancora visibili, sovrastati da un piazzale trapezoidale che occupava la terrazza superiore ed era circondato su tre lati da porticati. Un muraglione in opera poligonale,
tuttora conservato, sostruiva un livello superiore accessibile tramite scalinate e occupato da un sacello impreziosito
da pitture parietali e da un ricco pavimento a mosaico policromo di tipo ellenistico. L’intero complesso è il risultato di più fasi costruttive e venne quasi completamente obliterato da un’imponente frana nel corso del II secolo d.C.
Tra i numerosi reperti trovati nell’area del santuario nel corso degli scavi ricordiamo un’ara bronzea donata da un soldato nel II sec.d.C. e la bella statuetta
in bronzo di Ercole a riposo, attribuita all’artista greco Lisippo, donata al santuario intorno al 100 d.C. da un ricco armatore dell’epoca. Entrambi gli oggetti sono attualmente conservati nel Museo Archeologico di Chieti.
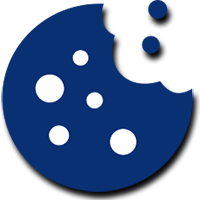












 per installare la App sul tuo
per installare la App sul tuo
